«Se Dio s’affacciasse per un attimo dal ciglio spumoso dei cirri in movimento, di là dall’orizzonte frastagliato di Monte Arlecchino, oltre a dare una gigantesca, improvvisa, luminosissima, e incredibilmente inquietante prova della sua esistenza, vedrebbe con il suo sguardo acuto e onnicomprensivo due ragazzi – Durante Salvani e Andrea Bui: in questo ferragosto di finesecolo, calcolando la giunta bisestile, rispettivamente di diciassette anni, otto mesi e ventiquattro giorni il primo: moro, quasicalvo, punteggiato dall’acne e dalla varicella come fossero battesimi epidermici di ogni suo picco nevrotico e amorale; a tre giorni dai suoi quattordici anni il secondo: i capelli castano chiari tracciati di rèsina, a spazzola, un’eterocromia delle irridi congenita che gli conferisce, da sempre, un’idea stevensoniana di doppiezza al tempo stesso solare e preoccupante; apparentati entrambi da una cuginanza prima e carnale: perché il padre del primo e la madre del secondo sono fratelli, Salvani entrambi: Alighiero e Bella, rispettivamente: tutt’e due portatori comuni di quei cromosomi che hanno, però, regalato a Durante una vita di inadeguatezze e di amori sfioriti sul nascere; di desideri appagati solo in virtù di una certa, sciamante simpatia nera e disperata in grado di supplire alle mancanze innegabili (eppure affascinanti, ricordiàmolo) del fisico; e ad Andrea, invece, un carisma involontario di sovrana imperfezione (il naso troppo largo e schiacciato, l’attaccatura asimmetrica dei capelli, un eccesso di magrezza costante alternata a periodi di imbolsimento spurio che, al primo impatto, lasciano disorientati e con un senso di malattia leggera in agguato) che però, fuso e anzi sottolineato dalla meraviglia cangiante degli occhi, rende il secondo tra i due del blocco Salvani (mica vorremmo appellarci alla banalità nominale del cognome paterno, per sottolineare la tirannìa inarrivabile della biologia?) assolutamente sereno; e disposto all’esistenza e all’amore con la gratuità solare del suo genio (perché di questo anche, si tratta, nel caso di Andrea) ancora inappagato e fuorimira; e della leggerezza smemorata e colpevole (perché incomprensibile a chi càpita come un presente fortuito) della propria bellezza negli anni – li vedrebbe, questo Dio incerto sulla soglia, in una tacca precisa del tempo; in un secondo di consapevolezza estrema che in qualche modo li riguarda ma di cui non hanno nessuna coscienza.»
Il cinghiale che uccise Liberty Valance di Giordano Meacci
Il cinghiale che uccise Liberty Valance di Giordano Meacci: un complesso, intenso e commovente racconto postmoderno, dai rimandi e significati stratificati, dal tono beffardo e impegnato, in bilico tra commedia e tragedia, un romanzo corale che esplora il linguaggio, la forza e i limiti delle parole.
SINOSSI
Nell’immaginario paesino di Corsignano – tra Toscana e Umbria – la vita procede come sempre. C’è gente che lavora, donne che tradiscono i propri uomini e uomini che perdono una fortuna a carte. C’è una vecchia che ricorda il giorno in cui fu abbandonata sull’altare, un avvocato canaglia, due bellissime sorelle che eccellono nell’arte della prostituzione e una bambina che rischia la morte. E c’è una piccola comunità di cinghiali che scorrazza nei boschi circostanti. Se non fosse che uno di questi cinghiali acquista misteriosamente facoltà che trascendono la sua natura. Non solo diventa capace di elaborare pensieri degni di un essere umano, ma, esattamente come noi, diventa consapevole anche della morte. Troppo umano per essere del tutto compreso dai suoi simili e troppo bestia per non essere temuto dagli umani: “il Cinghiale che uccise Liberty Valance” si ritrova all’improvviso in una terra di nessuno che da una parte lo getta nella solitudine ma dall’altra gli dà la capacità di accedere ai segreti di Corsignano, leggendo nel cuore dei suoi abitanti.
Giordano Meacci parla del romanzo su RAICULTURA NETWORK
RECENSIONE
Il Cinghiale che uccise Liberty Valance di Giordano Meacci è un romanzo che stupisce e che stordisce, a mio parere uno di quei libri nei quali si fa fatica ad entrare subito dalle prime pagine ma dai quali, una volta entrati ed apprezzati, si fa altrettanta fatica ad uscirne. Superati i primi, difficili capitoli, se si ha il coraggio o l’incoscienza di riuscire ad abbandonarsi alla prosa ed allo stile articolato, fitto di personaggi, di storie, rimandi, significati che rimandano ad altri significati, ad altri rimandi ed altre storie, in cui si mescolano dialetto, lessico ricercato, gergo tecnico scientifico, filosofia e cultura popolare, sacro e profano, comicità e dramma, in un intreccio senza trama ma ricco di trame, di vita, di realtà divise eppure unite in un racconto corale in cui ogni voce è un micromondo dentro il già micro mondo di Corsignano, il tutto intessuto in un percorso narrativo ballerino che salta avanti ed indietro nel tempo tra eventi e ricordi, tra realtà e mito – a quel punto, se si sarà riusciti a farsi accompagnare in questo spettacolo – si potrà gustare appieno questa coinvolgente e preziosa esperienza narrativa.
Come si diceva, superato il primo capogiro iniziale, se si riesce a superare il disappunto che potrebbe manifestarsi nei confronti di un autore e di un libro impegnativo, forse si riuscirà ad affascinarsi e ad entrare in quel gioco dalla prosa complicata, ardita, labirintica, a volte dotta altre caciarona, e a scoprire che, in fondo, ci piace. E se ci piace, probabilmente ci piace parecchio. Ci si potrà stupire e impressionare del modo in cui Meacci riesca a tenere le fila di tanti registri, di tante informazioni, di quei significati che si moltiplicano, permutano, si riproducono ad ogni frase in una semiosi illimitata, per dirla alla Peirce, tanto affascinante quanto frustrante. Ma quello che ci appagherà sarà ritrovarsi a vagare per Corsignano come Apperbohr il cinghiale, ascoltando le voci dei Corsignanesi, ficcando il naso nei loro ricordi, sentendo i sussurri dei loro defunti, osservando spezzoni del film di Ford con il commento di sottofondo, lentamente, tutto ci apparirà sempre più naturale, verosimile, familiare, realistico, proprio laddove la finzione dichiarata da Meacci nelle incursioni metanarrative del suo narratore onnisciente ci avverte del contrario.
Ed è proprio questo gioco tra finzione dichiarata ed esperienza realistica che fa di Corsignano, dei suoi personaggi e degli eventi ordinari e straordinari che vi occorrono un romanzo postmoderno squisitamente italiano, affresco di una provincia toscana reale ed immaginaria, nel quale è difficile a volte stabilire quale è l’una e quale l’altra.
Ma Il Cinghiale che uccise Liberty Valance è pure un romanzo sul linguaggio. Anzi, forse si può anche azzardare l’ipotesi che sia proprio il linguaggio, uno dei protagonisti di questa storia: un protagonista che lega ed accomuna cinghiali e uomini. Come i limiti della parola impediscono ad Apperbohr di comunicare i suoi concetti agli altri cinghiali, le parole impediscono agli uomini di comunicare, come afferma lo stesso Apperbohr: “perché ora [ora che Apperbohr le intende n.d.r.] le parole non hanno significato, sono distruttive, invadenti, sono il male che interviene a spiegare quello che è già tutto lì”. Ed il linguaggio coinvolge anche il lettore, ed in questo senso è curioso notare come, dal momento in cui il cinghiale Apperbohr comincia ad intendere parole e concetti degli “Alti sulle Zampe” (gli uomini), sembri anche a chi legge di riuscire lentamente a riappacificarsi con la prosa di Meacci, (o forse è la prosa di Meacci che prende fiato dopo tale evento narrato alleggerendosi quel tanto da divenire più fluida?) trovandola più semplice da seguire. Che sia un effetto intenzionale conscio o un effetto inconscio dell’autore frutto di una qualche eterogenesi dei fini, oppure sia l’effetto di una familiarità progressiva da parte del lettore con lo stile dell’autore e con i suoi personaggi dopo i primi capitoli di palestra, non è chiaro. Quel che però sembra accadere è che più Apperbohr impara la lingua degli uomini, più il lettore impara a capire il Corsignanese, e forse anche il cinghialese, narrati in Meaccese.
Troveremo inoltre lungo il cammino dei giochi linguistici che personalmente mi hanno richiamato quelli che trovai nei racconti di John Barth, quale ad esempio:
«[…] perché da sveglio ricorda sempre qual’è il sogno, la consapevolezza scompare solo mentre dorme, all’inizio – trova sé stesso e cerca di uccidersi, con quell’altro Andrea che gli viene addosso e cerca di ammazzarlo. E ogni volta si sveglia mentre fanno a pugni, senza mai – mai – sapere chi ha vinto, dei due.
Solo che. Ora. Per la prima volta dacché si sogna. Andrea si rende conto che l’altro sé stesso ha gli occhi cattivi e azzurri. Tutt’e due azzurri e luminosi e lucidi e cattivi. Come il riflesso sul ghiaccio del Nardile; appena prima che lo crepi in acqua il primo sole della primavera.»
Quel “Solo che. Ora.” lascia spiazzati. Ma questo linguaggio aperto, assieme alla narrazione inconclusa, lasciano spazio ad altro, a quello che avrebbe potuto essere, perché non esistono parole per descriverlo, o forse esistono ma Meacci lascia che ad aggiungere quei pensieri e quelle parole in sospensione, ci pensiamo noi.
Tuttavia, il linguaggio viene esplorato non solo come forma di comunicazione verbale o scritta di un messaggio, ma anche dal punto di vista della ricezione, della percezione e dell’interpretazione di chi riceve messaggi in altre forme e con altri sensi, la vista ad esempio, come succede al personaggio di Alvaro (affetto da una miopia grave sin da bambino):
«Alvaro venne gratificato dalla pergola spessa di una montatura nera, grossa; su due lenti molate un po’ alla buona e pietosamente sfumate in giallo. La prima volta che li indossò, un peso nuovo sul naso, una leggerezza mai avvertita dal cuore (e dal cervello), ad Alvaro sembrò il momento più strano e meraviglioso di tutta la sua vita. poi il cuore (e il cervello) gli strinsero in due terrori paralleli e incrociati, proiettandolo in un punto vicinissimo e nero del suo futuro. Si spaventò per quanto vedeva (epperò, mentre coglieva la ricchezza spropositata di quel regalo, la sua alvarità più profonda gridava di disperazione per tutto quello che, fino ad allora, aveva perduto). Poi si spaventò per il terrore che quella vista nuova e meravigliosa fosse un regalo a tempo. Qualcosa che avrebbe dovuto ridare di lì a poco indietro; con la sciagurata consapevolezza di chi, conosciuti i piaceri dell’hashish del Vecchio della Montagna, sia poi trascinato a calci in culo nella sua nuova vita di assassino drogato.»
La partenza ed il legante di tutta questa esplorazione del linguaggio e dei suoi limiti, è l’epifania del cinghiale Apperbohr, che si “sveglia” sulla frase “Ripènsaci, amico” del film L’uomo che uccise Liberty Valance di John Ford; una frase che dice tutto e niente, alla quale ognuno può cercare di dare il significato che vuole o lasciarla sospesa; del resto il cinghiale non ha comunicato con gli uomini, li ha solo sentiti e capiti, e tutto quello che è stato Apperbohr, quello che gli è successo, può benissimo non essere accaduto; così come noi lettori sappiamo benissimo dell’inesistenza di Corsignano, gli abitanti del paese sono all’oscuro dell’esistenza di un cinghiale che per un breve periodo li ha intesi, che li ha “letti”.
In tutto questo, ciò che rimane in noi è l’idea, appiccicosa, viscerale, che sia avvenuto qualcosa di straordinario nel paesino immaginario di Corsignano, e che noi tutti lettori, ne siamo stati testimoni.

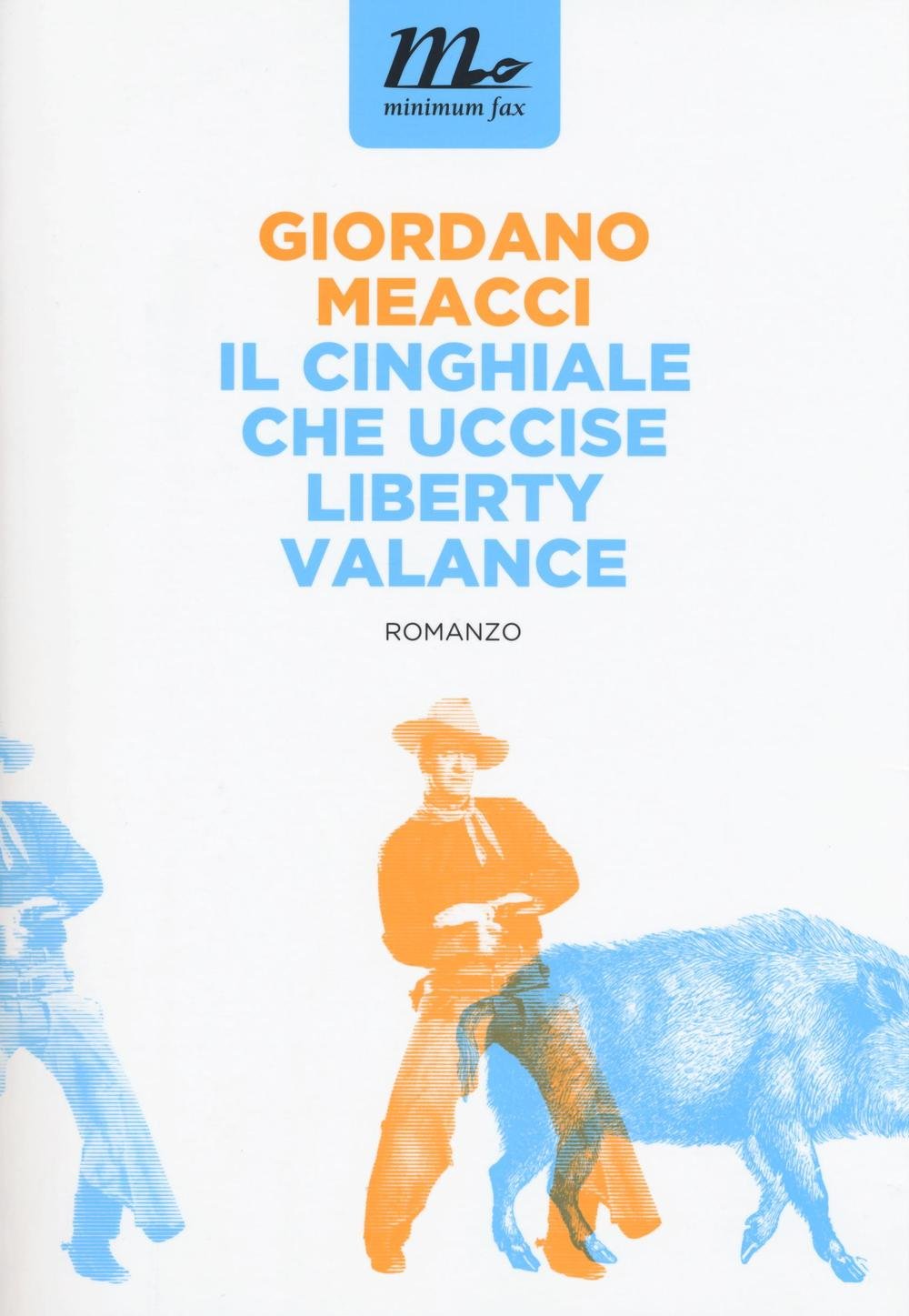




Rispondi